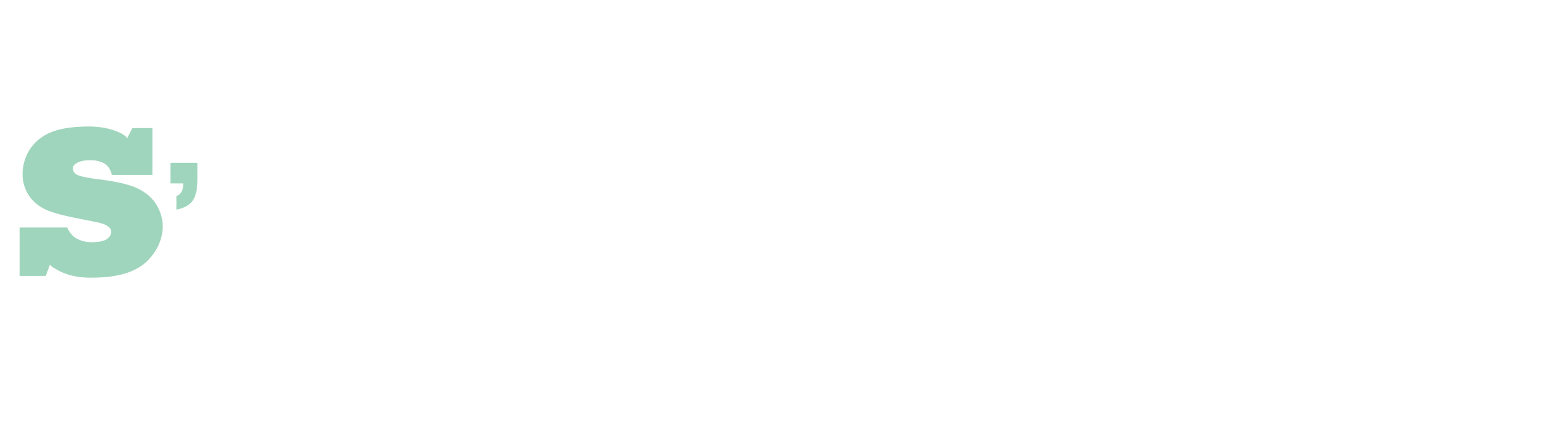L’identità della Sardegna tra narrazione e rappresentazione: dialogo con Carlo Pala
Nel corso della vita ci si confronta con una molteplicità di persone e atteggiamenti, spesso ambigui, compatiti, altre volte semplicemente accettati come parte del quotidiano. Si potrebbe dire che ogni individuo incontrato, in un dato momento della nostra esistenza, custodisce in sé un istinto – più o meno sopito – modellato o soffocato dall’esperienza dell’altro. Un carattere latente, non ancora emerso, e un vissuto che attende di essere riconosciuto, compreso, forse anche accolto.
Quando si parla di “auto orientalismo” in Sardegna, si fa riferimento a una forma di auto rappresentazione che i sardi stessi si sono costruiti, spesso inconsapevolmente, attraverso gli occhi delle esperienze altrui (e non ci interessa di chi).
Quel che ci interessa è che l’identità in questione viene “esotizzata” dall’esterno, marginalizzata e, in qualche modo, “distinta” dalla cultura occidentale dominante. Una descrizione postcoloniale dell’Oriente in quanto tale, un concetto sviluppato da Edward Said nel suo libro “Orientalism” (1978), dove si analizza il modo in cui l’Occidente ha costruito e manipolato l’immagine dell’Oriente per fini coloniali, culturali e politici. L’auto orientalismo rappresenta dunque una sorta di “internalizzazione” di questo sguardo coloniale.
I sardi sono stati manipolati?
«L’auto-orientalismo», dice a S’Indipendente il politologo Carlo Pala, «è una sorta di internalizzazione degli stereotipi che, per secoli, sono stati imposti ai sardi da dalle élite e dalle istituzioni centrali. A un certo punto, però, i sardi stessi, privati della loro dignità e della possibilità di esprimere una cultura indipendente, hanno cominciato a interiorizzare questa visione esterna e a definirsi in modo subalterno, come se il loro essere fosse destinato a rimanere una “curiosità” o un “anacronismo” rispetto alla modernità». Sembra, dunque, quasi una reazione fisiologica.
Ma come riconoscere questo fenomeno? Il nodo sta proprio nella narrazione che i sardi fanno di sé stessi e a cui sono abituati a fare affidamento. Lo sguardo che viene rivolto alla Sardegna è molto spesso quello di un’isola che non ha mai veramente fatto parte del “mainstream” continentale, un’area descritta come misteriosa e poco conosciuta, una sorta di “Oriente” in miniatura, lontana dalle dinamiche economiche e politiche del resto d’Italia. E il racconto che ne viene fuori è questo anche quando è un sardo a parlare: «Loro ci pensano così – si dice -, loro si aspettano questo da noi – si conclude in modo inconscio -».
In Fare, dire, sentire, Giulio Angioni riflette sulla costruzione dell’identità culturale e sulla dialettica tra l’identico e il diverso. L’antropologo critica esplicitamente l’immagine “musealizzata” della Sardegna: quella di un’isola immobile nel tempo, chiusa in sé, arcaica, intoccata dalla modernità. Secondo lui, questa rappresentazione è funzionale all’esotismo turistico, ma soprattutto è interiorizzata da molti sardi stessi, che finiscono per autorappresentarsi attraverso categorie imposte dall’esterno. In questo libro viene spiegato bene come una comunità può diventare prigioniera della propria immagine riflessa, soprattutto quando quella immagine è stata costruita da altri.
La riflessione anticipa molte delle critiche contemporanee all’auto orientalizzazione e al marketing identitario. Quel marketing che viene portato avanti solo perché “attira”. In questo senso, Angioni, anche se non usa mai esplicitamente il termine “auto orientalismo”, critica quegli intellettuali, artisti o operatori turistici che ripropongono immagini stereotipate dell’identità sarda – il pastore, il silenzio, la pietra, il rituale, la nostalgia – per rispondere alle attese del mercato o del centro culturale dominante – continentale o globale -.
Come si è arrivati a questo punto
Questo sguardo ha radici lontane. Durante il periodo del Regno di Sardegna, ma anche nei decenni successivi all’Unità d’Italia, la Sardegna è stata vista come un territorio arretrato, poco sviluppato, “selvaggio”, che non riusciva a stare al passo con il resto della nazione. E la stessa rappresentazione è sopravvissuta nei secoli successivi, spesso rinforzata dalla percezione che la Sardegna fosse troppo legata alle sue tradizioni per poter ambire a un futuro moderno.
Quella che nasce come una percezione esterna, nel tempo, si trasforma in una forma di pensiero interiorizzata dalla stessa società.
Pala racconta che questa dinamica è visibile soprattutto nei discorsi culturali e nelle scelte politiche che i sardi fanno riguardo alla loro identità. «Quando il popolo sardo guarda alla sua storia, molte volte non riesce a fare i conti con le proprie radici, ma finisce per cercare conferme fuori. Si aggrappa ai modelli che vengono dall’esterno, cercando di integrarsi in una cultura nazionale che, alla fine, lo considera solo un “margine”», continua. Questo atteggiamento non è solo un segno di una cultura esterna che ha imposto la sua visione, ma di un’incapacità latente, spesso, e per la maggior parte, imposta. Il sardo ha paura di confrontarsi con la propria identità in modo positivo perché è cresciuto con la convinzione che la propria identità sia “sbagliata”.
Quando ci fu il passaggio dal sardo come prima lingua all’italiano nelle scuole, il tasso di suicidi aumentò esponenzialmente. «Provate voi a vivere una vita in cui tutti, dalla famiglia agli insegnanti, ti fanno sentire uno scemo, un buono a nulla, solo perché parli una lingua diversa», rimarca il politologo.
Che cosa si intende per “Stato coloniale interno”?
Il concetto deriva sempre da lì, dagli studi postcoloniali, che hanno evidenziato come le logiche coloniali possano riprodursi anche dentro i confini nazionali, creando gerarchie territoriali e culturali. In questo schema, la Sardegna non è solo una regione marginale, ma è costruita come “altro interno”, cioè come una realtà che deve essere “modernizzata”, “civilizzata”, “integrata”, ma mai veramente ascoltata o trattata da soggetto politico pienamente autonomo.
L’insularità della Sardegna non è solo una questione di trasporti o logistica: è un elemento di costruzione dell’alterità. L’isola è spesso raccontata come “lontana”, “diversa”, “misteriosa” – un luogo da guardare da fuori, da esplorare, da interpretare, non da abitare pienamente nella cittadinanza. Il mare, più che un collegamento, è stato pensato e gestito come una barriera: nei collegamenti (trasporti marittimi e aerei), nell’accesso ai servizi, nella centralizzazione amministrativa.
Più del 65 per cento delle servitù militari italiane si trova in Sardegna: basi Nato, poligoni di tiro, zone interdette. Intere porzioni di territorio sono occupate per finalità statali e sovranazionali, senza reale possibilità di decisione da parte della popolazione locale. Questo è forse l’aspetto più concreto del “colonialismo interno”: lo Stato centrale utilizza l’isola come “spazio utile” per esercitazioni e attività militari, mentre gli abitanti subiscono i vincoli e i danni ambientali – e sanitari – conseguenti.
Con ordine
Il fenomeno dell’auto orientalismo si può riconoscere, secondo Pala, anche nei modi in cui la Sardegna viene rappresentata nelle produzioni culturali locali. «Molto spesso», dice, «i film, i libri e anche la musica tendono a rimanere ancorati a un’immagine stereotipata di una Sardegna che vive di tradizioni e folklore, come se la modernità fosse incompatibile con l’identità sarda». La stessa retorica del “ritorno alle origini” rischia di alimentare un’idea di Sardegna come una terra che non è in grado di evolversi, ma che è destinata a rimanere immutata, un reliquato del passato. Giovanni Columbu (nato a Nuoro nel 1958) è un regista e il film che più lo rappresenta è Su Re, una rivisitazione della Passione di Cristo interamente girata in Sardegna, in lingua sarda e con attori non professionisti, provenienti dalle comunità locali. Su Re non è una semplice “versione sarda” della vicenda evangelica, ma un’operazione di trasfigurazione simbolica: Cristo diventa ogni uomo, e la Sardegna diventa l’archetipo di un’umanità dolente e sacra.
Ma soprattutto, Su Re è una risposta potente a un certo cinema che guarda alla Sardegna come terra esotica o folklorica. Columbu rifiuta la narrazione della Sardegna come “scenografia pittoresca” fatta di pastori silenziosi, donne in costume, riti misteriosi. Quel tipo di immagine – costruita spesso da registi esterni, ma talvolta anche accettata o alimentata dagli stessi sardi – è ciò che potremmo definire quel che fino a ora abbiamo chiamato auto orientalismo.
Come ha osservato Francesco Faeta, antropologo, anche la rappresentazione antropologica e fotografica del Sud nel Novecento ha spesso contribuito a consolidare un “sud pittoresco” e statico, finendo per “esotizzare” il meridione in modo analogo a quanto l’orientalismo ha fatto con l’Oriente. Tutto questo è funzionale a un consumo dell’alterità, e sono spesso interiorizzate dai sardi stessi, generando forme di autocompiacimento identitario.
Rompere la linearità della visione folkloristica
Poi c’è la politica, non indenne dallo stesso virus che ha colpito la cultura. La Sardegna ha lottato per decenni per ottenere una maggiore autonomia, ma spesso i discorsi autonomisti sono stati pervasi da un’immagine che non è mai riuscita a emanciparsi completamente, come se la sua richiesta di autonomia fosse un atto di difesa di una cultura minacciata, e non un’affermazione di una forza politica legittima e matura. «Questa visione vittimista», dice Pala, «ci ha fatto vedere l’autonomia come un’esigenza di tutela, piuttosto che come una possibilità di crescita».
Eppure, secondo il professore, una via d’uscita esiste. Si tratta di smettere di pensare la Sardegna come un’isola di passaggio, un luogo da cui si è costretti a fuggire. Forse ci si potrebbe concentrare sulla nostra capacità di costruire un’identità nuova. L’auto orientalismo si combatte con la consapevolezza. «La Sardegna deve liberarsi da quella visione di sé che l’ha relegata a una “curiosità”», conclude Pala. «Solo così potremo affrontare il futuro con maggiore consapevolezza e dignità».
Riconoscere sé stessi nell’altro, dunque, senza mai dimenticare che, quell’altro, potrebbe anche non piacerci.
Foto di copertina: Francesca Arcai