
Sull’accoglienza reverenziale di Emanuele Filiberto
La domanda è: ma perché per una parte di società sarda l’accoglienza reverenziale di Emanuele Filiberto di Savoia è “normale” e non problematica?
In Sardegna ci sono due sistemi culturali in rapporto non paritario: la cultura dominante, italiana, e quella autoctona. Quest’ultima, per quanto tutelata in quanto minoranza linguistica, si trova a dover resistere ai processi di italianizzazione e sopravvive in un contesto socioculturale italofono, italocentrico ed eurocentrico.
L’italianità è un costrutto culturale che è stato funzionale al processo di costituzione dello Stato-nazione. Tale processo si è basato — e si basa — sulla creazione e sul consolidamento di una forte identità nazionale, mettendo in atto pratiche di esclusione nei confronti della componente sarda e sardofona, tanto che essa non trova rappresentazione nelle istituzioni, nel sistema dell’istruzione e dell’accademia, né nei media.
L’italianità della Sardegna è un’idea la cui rappresentazione è stata fondata su tre principali elementi:
1) La romanizzazione, un processo di acculturazione che proverebbe una base storica di appartenenza e continuità (la romanizzazione ha riguardato un territorio geograficamente vasto; in realtà, quindi, non si capisce perché debba valere più per la Sardegna che per altri territori);
2) L’italianizzazione primaria dell’isola sotto la dominazione pisano-genovese (Basso Medioevo): il periodo storico post-giudicale è raccontato come un “dominio” di Pisa e Genova, una narrazione quanto meno sbilanciata.
3) I Savoia come restitutori della Sardegna all’Italia dopo i “secoli bui” del periodo spagnolo.
Una parte della società sarda non ha mai messo in discussione il potere regio: ad attestare l’attaccamento popolare alla casa reale dei Savoia c’è il risultato del referendum del 1946. In Sardegna la monarchia vinse a mani basse (a Cagliari ottenne il 72%). Non c’è stata consapevolezza diffusa in merito alla coincidenza tra la condizione di povertà della Sardegna e i soggetti politici al vertice del sistema che l’ha mantenuta tale (attraverso il mantenimento delle strutture socioeconomiche del feudalesimo).
Il collegamento con il Piemonte rappresentò, per una parte della classe dirigente sarda, un motivo di prestigio: per la propaganda filosabauda i Savoia avevano offerto alla Sardegna la possibilità di uscire dall’arretratezza, retaggio dell’epoca spagnola.
Nella compagine popolare, la riverenza verso i Savoia è spiegabile con il fatto che parte della popolazione indirizzava il malcontento contro la classe feudale più che contro i sovrani piemontesi.
Non è raro che i rappresentanti delle monarchie siano accolti con favore dai popoli che hanno subito varie forme di dominazione: è una delle conseguenze della sudditanza.
La propaganda monarchica si è basata per secoli sul diritto divino e sull’idea che i popoli fossero come dei minori, bisognosi di essere guidati perché inconsapevoli e quindi incapaci di autodeterminarsi.
Sono stati gli studi postcoloniali (verso i quali in Sardegna c’è una certa resistenza) a offrire strumenti critici per analizzare le relazioni di potere. In quest’ottica, la sudditanza verso soggetti politici che si sono avvantaggiati della condizione di subalternità della Sardegna può essere interpretata come un sintomo.
Un sintomo di sindromi che affliggono la società: sindromi causate dalla scarsa consapevolezza di sé, da rimozioni e ipocrisie, dal mancato confronto con il proprio passato.
Il disprezzo dei Savoia nei confronti del popolo sardo emerge dai dispacci reali; la politica di sfruttamento sistematico delle risorse sarde, a vantaggio di un “centro” collocato nel continente, è palese.
Per spiegare la mancata crescita della Sardegna si utilizzarono concetti come “arretratezza” e “sottosviluppo”, imputati a una presunta incapacità dei sardi di emanciparsi.
L’unione con l’Italia è stata vissuta come un passaggio obbligato per il progresso, un destino comune a molti popoli negati. Negati anche perché privati degli strumenti per rapportarsi con la storia che li riguarda in modo critico: per leggerla con coscienza di sé.
Generalmente la cultura dominante si identifica con “ciò che deve essere”, proponendo modelli di riferimento che la cultura subalterna assimila senza metterli in discussione.
C’è poi una questione molto delicata che vorrei sollevare.
Sarde e sardi lo siamo tutti, qualsiasi sia -nell’ampio spettro dell’identità- il punto in cui ci si colloca, tra quei due poli.
La parte di società resistente ai processi di italianizzazione È una minoranza. Come tale esprime delle istanze, come è suo pieno diritto: si sente appartenente a un popolo, ritiene che i Savoia siano un simbolo di oppressione, di saccheggi sistematici e che abbiano ingiustamente e violentemente perseguitato le persone rivoluzionarie che hanno lottato per il sogno di una Sardegna libera e prospera. Questa parte della società ha diritto di esistere, di essere compresa nel sistema democratico, di essere inclusa nelle forme di cura, solidarietà e tutela che si suppone, come società civile, dovremmo praticare. E dovrebbe essere abbracciata in tutti i contesti dove si parla di intersezionalità, deghinò no est una pràtica po sconciai unu sistema de poderi.
Est a no lassai nisciunus apalas.
È vero che la lotta per l’autodeterminazione dovrebbe integrare metodi e pratiche intersezionali per essere davvero una lotta di liberazione, ma è altrettanto vero che serve far crescere la “cuscèntzia” negli spazi collettivi che si definiscono intersezionali.
Ecco, questa è una cosa che ho già detto, che ha scontentato chiunque, ne comprendo le ragioni. Per me non è un buon motivo per non rivendicarla.
Dire che l’accoglienza di Emanuele Filiberto di Savoia è problematica non dovrebbe essere un accollo soltanto della minoranza, ma di tutte le persone che -guardando alla storia- possono facilmente riscontrare i soprusi subiti dai sardi. E il sacrificio dei rivoluzionari. Siamo sarde e sardi tuttə, o vogliamo far finta che quei due sistemi culturali non siano entrati in conflitto e che questi attriti abbiano comportato forme di esclusione e discriminazione?
Non è ora di elaborare collettivamente la questione e cominciare a parlare di responsabilità collettive?
Un commento
Lascia un commento / Cummenta
I commenti saranno sottoposti ad approvazione prima della pubblicazione.
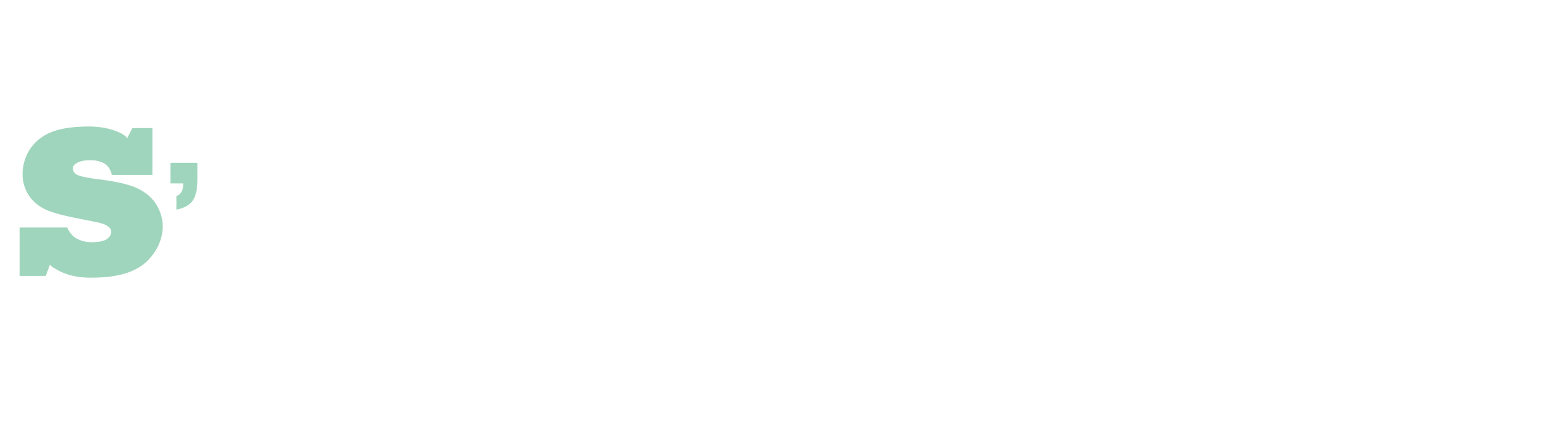



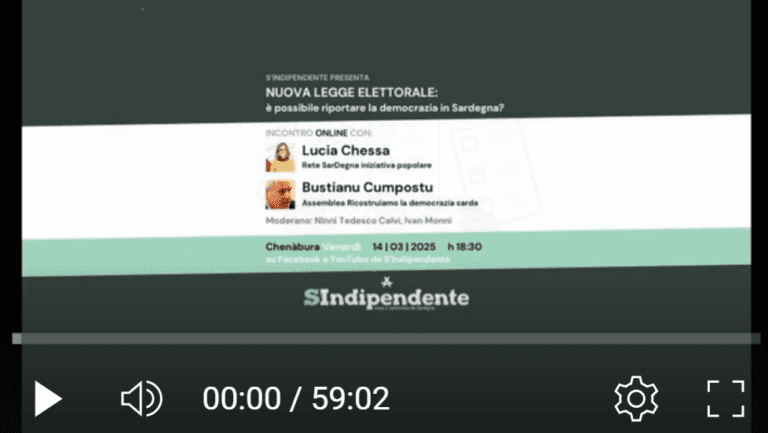






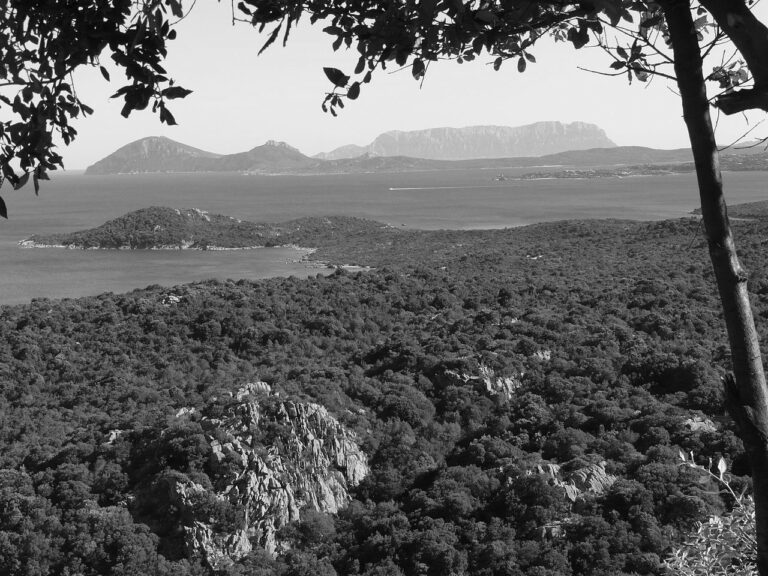





Concordo su tutto. Aggiungo che anche per gli italianisti dovrebbe essere un problema ricevere con onore un signor nessuno.
E consiglierei a tutti di attenzionare eventuali doni presentati dalle istituzioni a tale personaggio, perché essendo lui un privato cittadino non ci sono gli estremi legali per presentargli regalie a spese dei contribuenti. Sono certo che la corte dei conti sarebbe felice di sapere: combattiamo Is tzeracus con le istituzioni italiane che tanto amano …