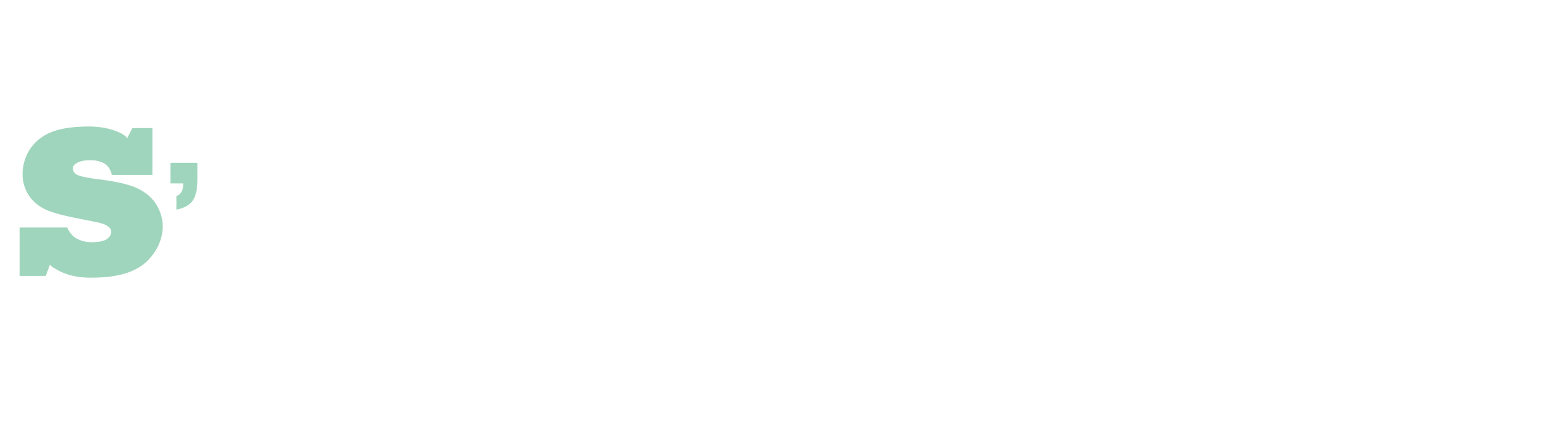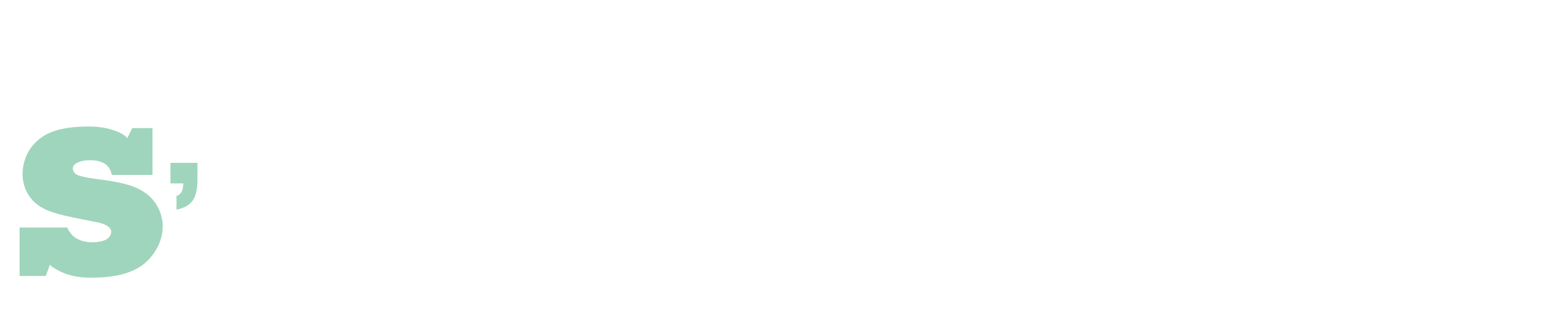De Omar Onnis
Il 2 giugno è la festa della repubblica italiana. Il suo significato è sempre stato debole, nel corso dei decenni, nonostante il tentativo di far riemergere il sentimento nazionalista risorgimentale, specie durante il settennato presidenziale di Carlo Azeglio Ciampi. Tale inquadramento è rimasto comunque attivo e ha assunto nell’ultimo trentennio un carattere egemonico sui mass media, nelle istituzioni e in larga misura persino nella scuola pubblica.
Al di là della retorica e dell’ipocrisia, il passaggio storico dalla monarchia sabauda alla repubblica e dal fascismo alla democrazia liberale in realtà è stato molto meno drastico di quanto si possa pensare. Non solo gran parte delle strutture del potere e del personale che le occupava rimasero al loro posto, ma pressoché da subito fu chiaro che gli stessi alti valori sanciti dalla costituzione repubblicana erano interpretati in modo vago, spesso minimalista, ovvero ignorati del tutto. Quando si celebra retoricamente la bellezza della costituzione italiana (magari senza averla letta e senza conoscerne altre), andrebbe sempre tenuto presente che un conto sono le dichiarazioni di principio, sia pure ammantate dallo status di “norma fondamentale”, un altro la loro declinazione concreta. Lo stato italiano, anche in epoca repubblicana, non è mai stato uno stato pienamente democratico, se non per alcuni elementi, certo rilevanti, ma che non bastano a eliminare ogni dubbio e riserva.
Tanto per questioni geopolitiche, quanto per questioni di equilibri di potere interni, la repubblica italiana è stata da sempre ostaggio di contraddizioni e di conflitti più o meno latenti, portandosi appresso una falsa coscienza della sua stessa storia, rimuovendo i problemi della stessa formazione dello stato italiano unitario, il suo passato colonialista e in larga misura lo stesso fascismo. La classe dirigente italiana si è sempre dimostrata estremamente gretta e di basso profilo, provinciale e vittimista, clientelare e anti-popolare. Gli intrecci tra parti dello stato e interessi opachi sia politici sia economici è stato sistematico, ivi compresa la convivenza pacifica e collaborativa con la mafia. La repressione violenta delle istanze popolari e progressive è stata la regola, con la fase acuta e drammatica della strategia della tensione. Nemmeno il trauma di Tangentopoli e degli attentati mafiosi tra 1992 e 1993 ha mutato sostanzialmente il quadro: lo ha solo aggiornato, producendo interventi su qualche regola formale e favorendo la sostituzione parziale della vecchia classe politica con un’altra non certo migliore. La classe dominante, con i suoi intrecci di interessi e di favori con la politica, è rimasta pressoché la medesima.
Quale che sia il giudizio che possiamo oggi dare della storia repubblicana italiana, in questa sede è tuttavia più urgente domandarci cosa sia stata questa storia per la Sardegna e dunque che senso abbia per l’isola la celebrazione del 2 giugno.
Teniamo presente che la Sardegna è da sempre sottoposta a una ferrea egemonia culturale di matrice nazionalista italiana, dalla toponomastica alle celebrazioni scolastiche, con tanto di dosi massicce di militarismo e il non raro coinvolgimento di scolaresche in manifestazioni platealmente scioviniste.
Il fallimento dell’Italia come stato pienamente democratico si riverbera nella provincia oltremarina sarda con aspetti ulteriori e con fenomeni locali che, se messi nel giusto rilievo, ne rivelano la natura posticcia e profondamente reazionaria.
Iniziata con un’autonomia “ottriata” (ottenuta per concessione dall’alto), per giunta debole e sotto tutela, la storia repubblicana della Sardegna è un susseguirsi di crisi e soluzioni sbagliate, di grande retorica e fallimenti concreti, di pessima politica e subalternità sistematica. Nel caso sardo, le relazioni internazionali, a cominciare dagli esiti del secondo conflitto mondiale e dalla conseguente collocazione geopolitica dell’Italia, hanno avuto un peso notevole. La destinazione dell’isola a territorio sottoposto a usi militari, concordata tra governo italiano e governo USA, è un fattore ingombrante e ancora fin troppo attuale nella nostra storia repubblicana.
Politicamente, la conquista della democrazia formale non ha significato per la Sardegna una compiuta conquista di una democrazia reale. Sia per i limiti storici della democrazia italiana, sia per la sua particolare declinazione sarda. Indebolito e marginalizzato il sardismo fin dalla fine della seconda guerra mondiale, la scena politica isolana è stata occupata dalle succursali dei grandi partiti italiani. Il modello politico dominante si è rifatto alla lezione di Francesco Cocco Ortu e dei suoi emuli, nel periodo tra fine Ottocento e inizio Novecento, modello ben descritto nella relazione governativa di Francesco Pais Serra del 1896 e stigmatizzato tanto da Antonio Gramsci quanto dal primo sardismo. Le consorterie che dominavano tanto nelle città maggiori quanto nei centri minori si sono ritagliate uno spazio di potere dentro le organizzazioni politiche e hanno assunto il ruolo di intermediazione tipico, mutatis mutandis, della classe dominante sarda dalla Restaurazione a oggi. La subalternità culturale dell’isola è stata solo in parte bilanciata dalla scolarizzazione di massa e dall’accesso più diffuso ai gradi superiori dell’istruzione. Processo che ha avuto i suoi aspetti contradittori e persino confittuali. L’italianizzazione linguistica e l’imposizione di una mitologia identitaria debilitante, a tratti rivendicazionista, ma sempre tributaria verso la cultura e la storia dell’Italia sono stati fenomeni macroscopici di questi decenni. Da cui deriva il marcato provincialismo del ceto medio istruito e del ceto intellettuale nel suo insieme.
La condizione socio-economica della Sardegna, in epoca repubblicana, è stata sempre pesantemente condizionata da scelte calate dall’alto e dall’esterno, assecondate dalla mediocrità e dalla scarsa autonomia della classe politica locale. La pesante emigrazione di massa, specie tra anni Cinquanta e Settanta, mai cessata del tutto e ripresa poi con ritmi meno imponenti ma costanti negli ultimi vent’anni, ha indebolito il tessuto demografico dell’isola. L’impoverimento demografico è figlio della stessa modernizzazione “passiva” subita dall’isola, già a partire dal secolo XIX, ma soprattutto nel secondo dopoguerra, in particolare col Piano di Rinascita. A sua volta è concausa di molti dei problemi attuali, con l’invecchiamento della popolazione, la mancanza di dinamismo economico, la difficoltà nel ricambio politico e culturale, l’abbandono di consistenti porzioni di territorio, la vulnerabilità a speculazioni di ogni tipo.
A 76 anni da quel 2 giugno 1946, il rendiconto che possiamo stilare oggi è molto più negativo che positivo. Non bastano la retorica costituzionale e il relativo “patriottismo” (italiano) a cancellare i fallimenti e le responsabilità politiche di questi decenni. Se consideriamo in tutti i suoi aspetti la nostra storia recente, c’è da stupirsi che in Sardegna l’opzione politica indipendentista sia rimasta minoritaria. Almeno in termini di consenso elettorale. In realtà sappiamo, da diverse rilevazioni, che il sentimento di rivendicazione verso lo stato italiano e l’aspirazione all’autodeterminazione sono molto più estesi e diffusi di quanto dicano i numeri delle elezioni. Anche questo è il segnale di una democrazia incompiuta, laddove le istituzioni rappresentative non accolgono affatto una proiezione realistica delle reali sensibilità politiche della popolazione. E non è solo un problema – pure vero e grave – di legge elettorale regionale. L’attuale quadro politico è desolante, a voler usare un eufemismo. Non c’è chi non se ne renda conto. In attesa di vedere come va a finire la presa in giro pericolosissima della “insularità in costituzione” e intanto che assistiamo ai soliti traffici di bassa lega tra le bande che si contendono cariche e posti di potere (la cronaca politica sarda parla prevalentemente di rimpasto di giunta, in queste settimane), la ricorrenza del 2 giugno ci offrirà il solito spettacolo retorico senza capo né coda, da scalcinata periferia dell’impero. È del tutto lecito rifiutarsi di prendervi parte e anzi contestarne spirito e forme. Proprio in nome di quella democrazia che l’avvento della repubblica avrebbe dovuto finalmente realizzare e non ha saputo fare.
Il 2 giugno, in definitiva, dovrebbe servirci non tanto a celebrare alcunché, quanto piuttosto a farci delle domande. E, dopo le domande, sarà bene che cominciamo anche a darci delle risposte.