Sono i sardi un popolo indigeno? Chi sono, se ci sono, i popoli indigeni europei e perché son chiamati tali? Prova a far chiarezza Antonio Fadda, con il primo di una serie di articoli incentrati su questo importante tema. Antonio vive e lavora in Canada. Laureato in Filosofia, è stato assistente all’Università della British Columbia, partecipa attivamente a varie iniziative – in Canada e online – per la rivitalizzazione della lingua Sarda. È membro dell’Associazione Sardos In Canada.
De Antonio Fadda
La lotta contro un recinto: sovranità ambientale e indigenismo
L’antropologa canadese Tracey Heatherington ha scritto una bellissima etnografia incentrata sulla pluridecennale lotta della comunità di Orgosolo contro l’istituzione del Parco del Gennargentu. Il suo libro, purtroppo disponibile solo in inglese, titolato “Sardegna Selvaggia. Indigenismo e Tempo del Sogno dell’Ambientalismo” è un ottimo punto di partenza per una riflessione sul tema dell’indigenismo perché qui l’autrice si interroga in modo mai banale sull’applicazione di questa categoria ai sardi. L’accostamento è chiaramente in parte provocatorio come Heatherington stessa ammette:
La mia comparazione tra gli abitanti della Sardegna rurale e i popoli indigeni è volutamente provocatoria, ma non semplicistica. I sardi oggi, sia come Europei che, come attivi partecipanti nel mondo moderno, occupano uno spazio ambivalente se messi faccia a faccia con definizioni convenzionali di “indigeneità”: il loro caso rivela il modo paradossale in cui il conservazionismo ambientale usa e manipola rappresentazioni di diversità culturale.
Heatherington, 2010

Il parallelo dei sardi con i popoli indigeni emerge a partire da quella che lei chiama “abitazione sociale“ del territorio inteso come legame profondo di alcune comunità dell’entroterra sardo con il loro territori circostanti per mezzo di usi, consuetudini e saperi che, dato il loro carattere relazionale con la terra, permettono di istituire un parallelo con sistemi di saperi indigeni di altre parti del mondo. L’altro carattere che secondo l’autrice accomuna popoli indigeni e sardi è la comune marginalità alimentata da centri di potere e istituzionali trans territoriali che mantengono in piedi narrazioni marginalizzanti per esercitare forme di controllo che inficiano la sovranità territoriale delle stesse comunità.
A tal fine, Heatherington procede a documentare il modo in cui direttive conservazioniste di ambito Europeo e internazionale, abbracciate acriticamente da organizzazioni ambientaliste come il WWF, abbiano negli anni caldi dell’opposizione al parco, portato avanti una battaglia che ricorreva a narrazione stereotipate dei sardi come popolo chiuso all’innovazione, incapace di accogliere il progresso arrecato da un parco che, nelle intenzioni dei promotori, avrebbe portato sviluppo e modernità a un territorio atavicamente sottosviluppato.
Per usare le parole di Heatherington:
Secondo la narrazione del WWF, questi territori sono rimasti esempi “relativamente intatti” di ecosistemi Mediterranei del passato. Gli abitanti di queste zone rurali che oggi posseggono questi territori sono invece rappresentati come intrappolati tra una sorpassata economia pastorale – che pascola su pascoli naturali e usa spesso il fuoco per ripulire il terreno – e una cultura consumistica che valorizza il benessere materiale aumentando così la pressione sulle risorse del territorio. L’opposizione al parco viene interpretata come un altro esempio di anacronismo culturale: la paura di perdere i diritti tradizionali di usufrutto sulle terre comuni viene trattata come irragionevole arretratezza. Per il WWF, solo la creazione del parco nazionale, con il dispossessamento delle comunità, permetterebbe le trasformazioni culturali ed economiche volte a proteggere gli habitat sardi attraverso l’istituzionalizzazione di competenze ecologiche, le uniche in grado di disseminare valori conservazionisti e ambientalisti.
Heatherington, 2010
Sono passati più di vent’anni dal lavoro sul campo di questa ricerca. Come si sa, il Parco del Gennargentu non ha mai visto luce. Qualche giornalista, tradendo la sua solidarietà al progetto, ha scritto che il parco è morto per “inedia” ma la verità è che il parco è morto per un’opposizione organizzata e cosciente delle comunità incluse nella perimetrazione, che intuirono il grave pericolo di un ente parco calato dall’alto le cui maglie burocratiche avrebbero interferito con il diritto delle comunità di continuare a godere degli usi tradizionali di quei territori. Tuttavia, rispetto a questa questione non bisogna fare un’associazione ingenua tra interessi tradizionali e preservazione del territorio. La stessa Heatherigton attesta che a partire dalla fine degli anni ’70, alcuni pastori smisero di rispettare i vincoli consuetudinari de su vardau, un periodo di riposo de su cumonale che veniva imposto a tutti; il rifiuto di una minoranza di obbedire a regole consolidate per il proprio tornaconto generò il massiccio disgregarsi di consolidate usanze e regole di sfruttamento del territorio comunale che erano volte alla sua preservazione, portando così a conflitti sociali con ricadute criminose che impongono una riflessione non semplicistica. Tuttavia, non è forse questa un ulteriore conferma del fatto che la costituzione di un parco nazionale non avrebbe fatto altro che inasprire la degradazione di saperi, usi e costumi tradizionali esacerbando i conflitti?
Al di là della necessaria pillola di realismo imposta da una riflessione sul decadimento delle consuetudini, è certamente vero che l’ambientalismo e il conservazionismo della fine degli anni Novanta, non erano pronti ad accogliere l’idea che i saperi tradizionali delle popolazioni autoctone, indigene e locali contenessero già sofisticati sistemi di conservazione ambientale. È solo negli ultimi anni che le frangie più progredite della ricerca ecologica conservazionista hanno iniziato a lavorare in maggior sintonia con i popoli indigeni. Un rapporto del 2019 supportato dalle nazioni unite presenta dati empirici che confermano come le terre abitate e gestite dai popoli indigeni, ovvero un quarto delle terre emerse, sono meglio preservate delle restanti terre e la degradazione degli habitat e dei suoli avviene meno velocemente (Sneed, 2019). Alla luce di ciò, i velleitari tentativi di riapertura della questione del Parco del Gennargentu che di tanto in tanto riemergono per bocca di vari organi istituzionali, mostrano che i loro fautori son ben lontani dall’assunzione consapevole che la conservazione non passa dalla costituzione di enti e meccanismi burocratici calati dall’alto ma bensi dalla valorizzazione delle epistemologie e sistemi di saperi delle comunità locali. Ragion per cui, l’opposizione al parco-recinto calato dall’alto dallo stato italiano rimane ancora oggi non solo una necessità imprescindibile ma anche un capitolo fondamentale di presa di coscienza storica tutt’ora in atto.
“Wilderness“, una parola che maschera la storia di un crimine
Le insidie di nuove forme di dominazione ambientale si esprimono anche attraverso nuovi termini, spesso parole importate dall’inglese, che nascondono una storia che di rado viene raccontata. Oggi quando si parla di parchi e ambiente si parla spesso di “Wilderness“, parola divenuta d’uso comune anche in Italia. Eppure, bisogna chiedersi da dove vengono questi termini, cosa denotino, e quale sia il contesto storico ma anche evocativo che cercano di richiamare. Il termine “Wilderness” o “natura selvaggia incontaminata” può venir visto come una sorta di estetismo ideologico ambientalista nato durante l’espansione coloniale nordamericana. Nei suoi elementi basilari, questa visione promuoveva l’idea di una natura come luogo di mero godimento estetico da preservare non attraverso l’operato delle popolazioni autoctone, ma contro il loro operato che veniva visto come contrapposto agli interessi della conservazione. È una forma di paternalismo ecologico-ambientale che aveva l’effetto di sottrarre agibilità alle comunità locali indigene che avevano legami ancestrali con un dato territorio. Questa “ideologia” nasce in America nella seconda metà dell’800 attraverso quel processo brutale che portò all’istituzione dei primi parchi nazionali, come i rinomati Yellowstone Park (1872) e Yosemite Park (1890), con la conseguente esclusione e sterminio delle comunità indigene che da millenni abitavano e plasmavano quei territori.
David Treuer, attivista e scrittore di discendenza Ojibwe per parte di madre, ci ricorda che:
Vista dalla prospettiva della storia, Yellowstone è una scena del crimine
Treuer, 2021

La storia dello Yosemite non è da meno e, seguendo Treuer, vale la pensa soffermarvisi per comprendere il nesso storico tra ideologia conservazionista di marca coloniale, espropriazione ai danni delle comunità indigene e conseguente falsificazione del dato ambientale.
Nel 1851, il battaglione Mariposa fu il primo gruppo di uomini bianchi che posò lo sguardo sulla valle di Yosemite. Nel trovarsi di fronte allo spettacolo delle famose pale granitiche chiamate dagli indigeni “il luogo della bocca spalancata“, Lafayette Bunnell, membro del battaglione, riportava nel suo diario il senso di “esaltata meraviglia” davanti a tale spettacolo naturale. Egli annotava:
Un peculiare senso di esaltata sensazione ha riempito il mio intero essere e mi son trovato in lacrime
Lafayette Bunnell

Eppure, il suo battaglione non era certo entrato nella valle per ammirare il paesaggio; il battaglione aveva ben altra missione: sterminare la tribù indigena dei Miwok che rappresentava un ostacolo alle rotte espansive della corsa per l’oro (Gold Rush) nel nord della California. A tal proposito, va ricordato che lo sterminio delle tribù indigene native della California fu quello più efficiente e sistematico anche se meno noto e cinematografato rispetto a quello delle tribù delle praterie centrali. Si stima che il cosiddetto “Genocidio della California” portò, attraverso massacri condotti da milizie private, ma anche sponsorizzati da autorità di stato, a una popolazione nativa che si ridusse da 150,000 individui nel 1848 a 16,000 circa nel 1900. Sfortunatamente la tribù dei Miwok che abitava la valle di Yosemite venne annientata ben prima di questa data: chi non fu ucciso dal battaglione Mariposa, fu disperso, e quei pochi che sopravvissero vennero confinati in riserve. Agli stermini, sottolinea Treuer, si accompagnava sempre una narrazione che vedeva i dominati come individui culturalmente inferiori. Lo stesso Bunnell che aveva espresso sentimenti così sopraffini sulla natura selvaggia del Yosemite Park così si esprimeva sugli indigeni:
Ogni tentativo di governarli e civilizzarli senza il potere di farli obbedire, verrà visto da questi barbari con scherno… il selvaggio è naturalmente vano, crudele e arrogante.
Lafayette Bunnell
Niente male per un estimatore dei sublimi voli dello spirito dinnanzi agli spettacoli naturali. Per istituire un parallelo forse azzardato (dato il contesto di genocidio fisico oltre che culturale) ma pur sempre interessante con la Sardegna, la stessa Heatherigton si sofferma sull’analisi di programmi televisivi nazionali italiani, articoli di giornale e siti web che, con le loro rappresentazioni selettive, rinsaldano il tópos mediatico di un carattere di innato atavismo dei sardi, in particolare la loro presunta omertà.
A tal scopo, essa prende in esame una trasmissione di Santoro trasmessa il 18 novembre 1997. Il taglio dei servizi, gli individui selezionati a dovere dai giornalisti per prendere parola, le immagini della campagna di Orgosolo sovrapposta al covo dei banditi, le interviste preregistrate ai bambini e alle signore anziane che alludono alla paura di parlare, l’uso delle musiche dai toni sinistri, tutto confezionato a dovere per confermare l’idea degli Orgolesi omertosi. Infine il colpo di grazia, in collegamento da Roma nello studio di Santoro, gli striscioni che recitano “L’Omertà uccide”. A trasmissione conclusa gli Orgolesi convenuti in piazza son visibilmente sgomenti e agitati per aver partecipato a una vera e propria trappola con un finale già scritto; ma quante volte abbiamo assistito e ancora assistiamo a queste pagliacciate spacciate per informazione nei media italiani ma anche sardi? Non è un mistero che queste dinamiche sono tutt’oggi correnti nelle modalità in cui la televisione italiana parla dei sardi.
Tornando ai parchi nazionali americani, la storia mostra che trenta anni dopo l’entrata del battaglione Mariposa, la valle di Yosemite poteva finalmente diventare oggetto di quella venerazione per la “Wilderness” che reclama di preservare un territorio ripulito dagli esseri umani. Finalmente, come scrive sarcasticamente Treuer, quel paesaggio poteva “offrire agli Americani il brivido di guardare dietro le proprie spalle un mondo senza esseri umani e senza tecnologia“. Da luoghi vissuti, abitati, manipolati, preservati e sentiti dagli indigeni come intimamente loro, i neoistituiti parchi nazionali americani si trasformarono in quello che sono oggi nella concezione dei colonizzatori vincitori: “cattedrali naturali, paesaggi protetti dove le persone possono adorare il sublime“ (Treuer, 2021).
Treuer ci ricorda che uno dei padri del conservazionismo moderno in America, John Muir, sosteneva e patrocinava la necessità di creare spazi di natura vergine e intonsa, volti alla fruizione estetico-esperienziale di un mondo oltre quello umano e dove l’esperienza della meraviglia davanti alla grandezza della natura generasse un senso di effimera fragilità e piccolezza nello spettatore. Secondo Muir, l’America era stata immensamente favorita come nessun’altra nazione per questi “giardini selvaggi” naturali e tali spazi andavano tutelati a dovere come natura vergine.

Peccato però che questa narrazione fosse una menzogna colossale frutto di una mentalità coloniale che aveva già smantellato e vilipeso il ruolo delle popolazioni indigene nel plasmare quei territori. Nessun lembo del continente Nord-americano era una “Wilderness” da almeno 15,000 anni. Molti di quelli che diventeranno parchi nazionali erano già stati largamente modificati e manipolati dalle culture indigene che li abitavano. Le stesse querce nere che adornano la valle di Yosemite erano coltivate per le loro ghiande dai Miwok. Le popolazioni indigene manipolavano il territorio, la vegetazione e l’ecologia intera di vasti paesaggi favorendo determinate specie vegetali a loro volta favorite dalle specie di cervidi da loro cacciate e dando vita a massicce trasformazioni paesaggistiche ed ecologiche. La mano dell’uomo ha profondamente plasmato questi paesaggi da tempo immemore. Oggi Treuer si batte per riportare a galla la memoria storica di quel processo storico che portò all’istituzione dei parchi nazionali attraverso la tattica del furto della terra per mezzo di trattati firmati e poi annullati in breve tempo e reclama la restituzione dei cosiddetti “parchi nazionali” alle popolazioni indigene che ancora oggi spesso vivono a ridosso di quei territori.
Con i dovuti distinguo, l’ambientalismo operato in Sardegna da ONG come il WWF e altri enti istituzionali preposti, ha raccontato favole simili ed è sulla possibile risorgenza di queste favole che dobbiamo vigilare. Si è raccontata la favola di un Gennargentu terra vergine e in attesa di protezione dalla mano dell’uomo, cercando di obliterare i legami sociali profondi e intimi che legavano e legano i sardi di quei territori alla loro terra. Questi enti non hanno saputo cogliere la sfida di vedere quelle comunità come la risorsa principale per la conservazione. La loro visione verticalista e arrogante ha per fortuna fallito grazie all’opposizione dal basso di quelle comunità, che hanno sapientemente fiutato il rischio di venire espropriate delle loro prerogative e della loro connessione millenaria con quei territori. Tantomeno, questi legami possono essere riscritti dallo stato italiano o da chissà quale altro ente creato a tavolino in nome di un’esigenza di conservazione falsata che separa le donne e gli uomini dalla terra.
Alcuni popoli indigeni parlano di “domini ancestrali” a rimarcare il ruolo di guardiani e affidatari eticamente responsabili (stewardship) di un territorio. La gestione delle terre comuni secondo usi e convenzioni sociali tradizionali, laddove è sopravvissuta in Sardegna, rappresenta un importante parallelo con queste forme di gestione operate da comunità indigene. Laddove non si sono mantenute le consuetudini de su cummonale si può lavorare per studiare il passato e informare scelte future. La grande lezione che possiamo trarre dal movimento sardo, autoctono, di resistenza contro il Parco del Gennargentu è quella di ripensare il rapporto ancestrale di molte comunità con i loro territori, e più precisamente con quei territori rurali ma anche urbani, dove ci sentiamo profondamente radicati al fine di progettare una conservazione partecipata dal basso. Conservazione che, riconoscendo questa ancestralità del legame sociale verso il territorio, come per tante comunità indigene sparse per il mondo, fornisca le basi di una rinnovata coscienza politica, economica e soprattutto ambientale per tutti i sardi.
- Heatherington, T. (2010). Wild Sardinia. Indigeneity & the Global Dreamtimes of Environmentalism. University of Washington Press.
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2019). Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’ Species Extinction Rates ‘Accelerating’. https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
- Sneed, A. (2019, May 29). What Conservation Efforts Can learn from Indigenous Communities. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/what-conservation-efforts-can-learn-from-indigenous-communities/
- Treuer, D. (2021, April 12). Return the National Parks to the Tribes. The jewels of America’s landscape should belong to America’s original peoples. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/05/return-the-national-parks-to-the-tribes/618395/
Fotografia: wikipedia
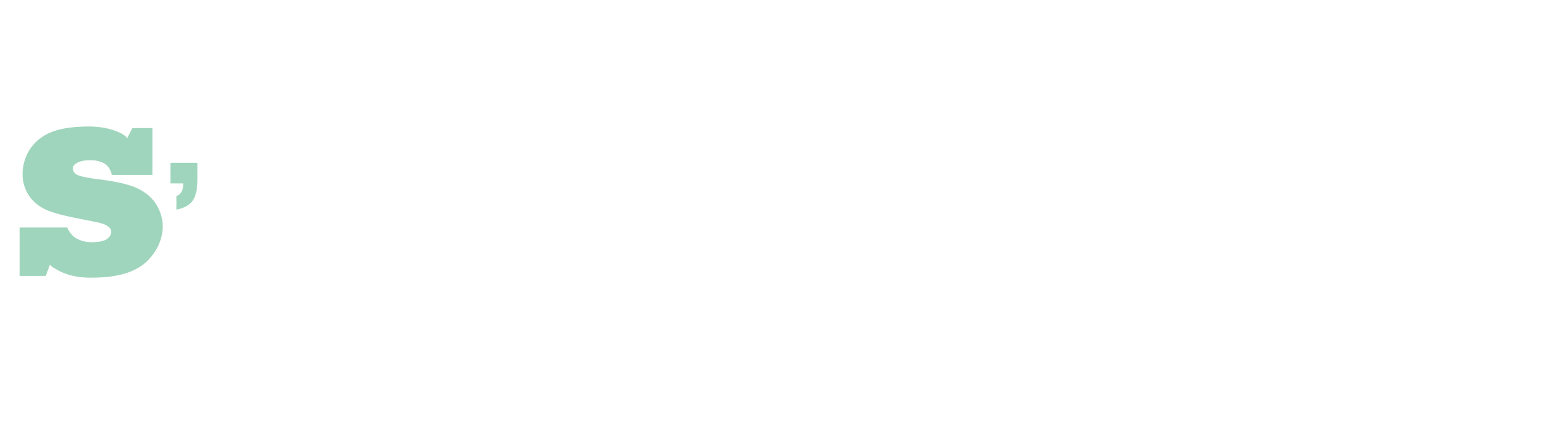









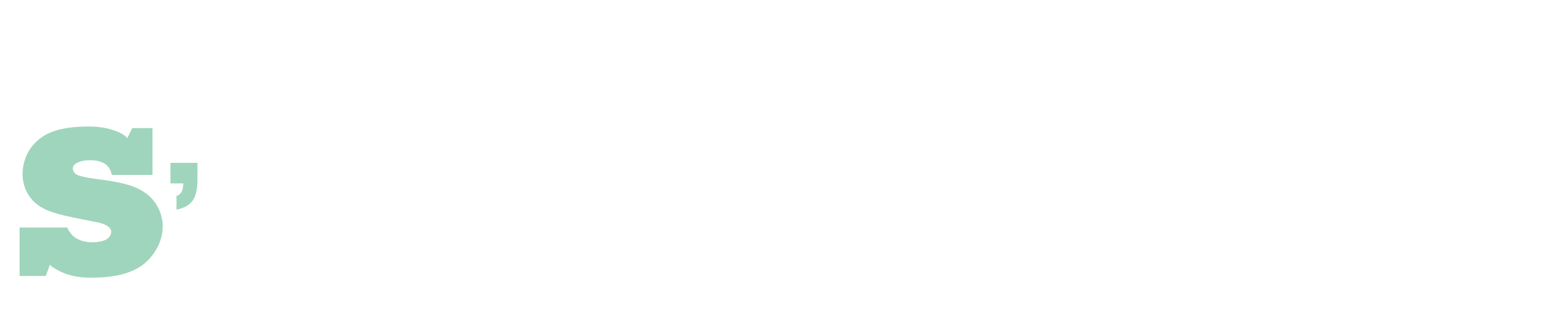
Il rapporto tra uomo e natura non è visto in maniera univoca ma, a secondo della cultura, ha assunto significati diversi, se non opposti. Il concetto di “wilderness” nordamericano vede l’uomo e tutte le sue attività come qualcosa che deve essere tenuto lontano dai santuari “naturali” circoscritti e limitati (John Muir). All’opposto Jean, allievo di Ivan Illic, considera l’uomo e le comunità a cui appartiene, come parte integrante del territorio in cui vive rispettando i ritmi di riproduzioni delle risorse accettando quindi il concetto di limite di riproduzioni di tali risorse. La prima concezione da origine anche alla contrapposizione tra città e campagna; storicamente è anche stata alla base delle conquiste territoriali, del colonialismo
Davvero un ottimo articolo, che copre la distanza linguistica con un libro veramente necessario per le sfide che affrontiamo oggi in Sardegna, prima fra tutte la questione della speculazione legata all’eolico e ad altri progetti su larga scala di impianti per l’energia rinnovabili imposte alle comunità della Sardegna rurale. Grazie Antonio!